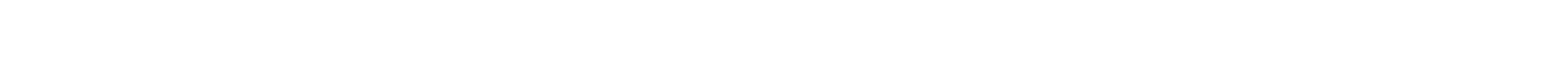

Uno spettro si aggira per la scena indipendente italiana. Lo spettro di P L Z. Un nome che è anche un modo per chiedere “permesso, posso entrare?”. Per favore, mi puoi far godere ancora una volta prima di sparire?
P L Z è uno spettro gentile, raramente si arrabbia, se non quando si collega a un terminale e allora le sinapsi entrano in cortocircuito con i miraggi, le storture della rete. Tenete lontano P L Z dall’internet e dai social: meglio farlo stare in mezzo a un bosco, magari con un discman anni ’90 calato sulle orecchie (le orecchie che non ha), a ballare da solo come in quella scena in “The Lobster”. Che poi da solo P L Z non è mai. Più spesso è bino. Altre addirittura trino.
Nelle sue epifanie più comuni lo troverete sdoppiato fra un vocoder e una beat machine, mentre sostiene la sua ombra e da lei è sostenuto.
Perché P L Z ha paura di tutto, tranne di ciò che gli può far male. Cieco per amore, non mostra il viso a nessuno. Un velo lo protegge, una maschera di lattice gli tiene insieme i connotati sempre a un passo dallo sciogliersi, dal distorcersi.
P L Z ama le tresche, gli interstizi, le zone buie fra un lampione e l’altro, attraversare la strada senza guardare. P L Z è fedelmente infedele. Non lo si sente per un po’, ma se lo chiami arriva, sempre. P L Z odiale gabbie, soprattutto quelle erette dall’isteria collettiva. Il suo motto è “vivi e lascia morire”. Anzi “dormi e lasciati fare”.
Lasciatevi fare da P L Z.
Please, please me.
